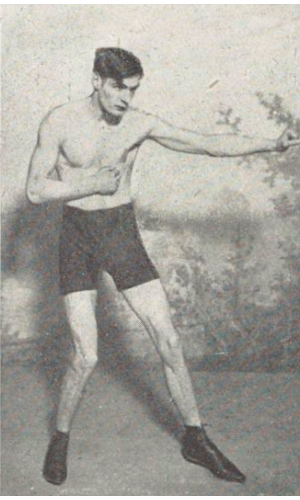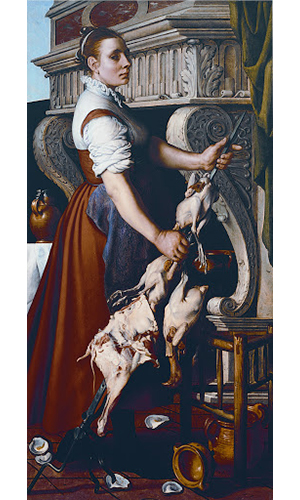Andrea: Daniele Costa, classe 1992, laurea al DAMS e poi ad Arti Visive allo IUAV, videoartista. Nel 2016 vincitore del 1° Premio 100esima collettiva giovani artisti Fondazione Bevilacqua La Masa. Ma chi è Daniele? E da dove è iniziata la tua passione per l’arte?
Daniele: Fin da quando ero bambino, sono sempre rimasto affascinato e rimango tuttora conquistato dai film. Ho una passione spasmodica per tutto ciò che si muove all’interno di uno schermo e il cinema è stato a tutto gli effetti il primo aggancio all’idea di arte e movimento. E soprattutto con l’idea di raccogliere tempo. Utilizzare un dispositivo che raccoglie del tempo che viene poi rielaborato e che a sua volta genera del tempo è un aspetto che continua ad affascinarmi. Accade che all’università seguo il corso di Guido Bartorelli (Storia dell’arte contemporanea ndr) che sin dall’inizio è un colpo al cuore. Da quel primo nostro incontro, il sodalizio con lui continua tuttora e ho anche avuto il piacere di vederlo presentare uno dei miei lavori al cinema Porto Astra. Ricordo che durante il corso, Bartorelli aveva un modo di raccontare l’arte che scardinava i paletti istituzionali, ti faceva entrare in dinamiche di interpretazione estremamente diverse da tutte quelle più convenzionali, così mi si è aperto un mondo.

A: Cosa ricerchi in ciò che andrai a filmare? Esiste un filo rosso che lega le tue opere?
D: Parte della mia ricerca verte sulla corrispondenza tra dispositivo video e corpo umano: entrambi accatastano esperienza e quindi tempo, lo rielaborano e lo rigettano fuori in modalità molto simili. All’inizio utilizzavo il video principalmente come mezzo, era pura sperimentazione. Giravo dei video molto corti dove il cuore erano le modalità di ripresa, oppure ciò che il video raccoglieva dentro di sé, o la trasposizione metaforica tra il video e l’esterno. Ho dovuto elaborare un percorso di conoscenza e scoperta graduale del mezzo che avevo in mano. Quando poi sono passato allo IUAV a Venezia, l’impostazione era molto più attiva e votata al produrre. Il corso tenuto da Angela Vettese (Teoria e critica dell’arte contemporanea ndr) richiedeva una modalità processuale dove era necessario capire velocemente dove arrivare e come. Angela è un mostro sacro dell’arte e con lei sono uscito dalla mia fase sperimentale: i lavori hanno così preso corpo in una modalità di racconto secondo la quale narrativa e storytelling sono entrati nella mia pratica. Non direi che il mio percorso di ricerca abbia cambiato metodologia nel tempo: il punto d’inizio è rimasto lo studio del corpo che da raccoglitore misero di tempo è poi diventato un ponte di collegamento con le storie delle persone che incontravo. Queste storie nascono dal fissarsi su un percorso di ricerca ben preciso.
Uno dei miei primi lavori (Corto “Spazio Morto”, vincitore della 100esima collettiva giovani artisti Fondazione Bevilacqua La Masa, ndr) mi ha permesso poi di fare una serie di giri ad appena 24 anni, sbloccandomi porte che fino ad allora non conoscevo così bene. E poi l’approdo al pianeta Venezia fa sì che si entri in contatto con artisti che masticano un linguaggio diverso. E quindi la crescita, lo scambio e la contaminazione sono stati esponenziali. Per fare un esempio di come nascono le storie di miei corti, Spazio Morto (2016) è un lavoro che raccoglie il tempo di una persona incontrata involontariamente, quasi per caso. Stavo immaginando e facendo un sopralluogo per un altro lavoro, ero insieme a Valentina Furian, artista amica, inizia a piovere e ci rifugiamo nelle casette dei bagnini dove abbiamo incontrato Papis, immigrato senegalese che si Lavorava come bagnino di terra ai bagni alberino, vicino aveva il suo orto e una capanna costruita sul mare, un orto e una capanna. Da lì ho capito che il processo è la parte più importante, soprattutto nell’arte contemporanea: rappresenta la chiave per farti vedere le cose in maniera diversa. L’arte non fa sì che tu compia miracoli ma deve attivare dei processi di visione che nella tua vita non faresti accadere spontaneamente, quindi dev’essere un modo per far saltare in aria qualcosa dentro di te, nella tua testa e nei tuoi occhi. Tutte le altre storie sono state una sorta di succedersi spontaneo e naturale all’interno del mio percorso di ricerca.
A: Iniziamo da una delle tue ultime opere in ordine cronologico ovvero “X – Meet the Unknown”, che si dispiega attorno alla piccola cittadina di Lago, appena 1000 abitanti. Qual è la genesi di questo tuo lavoro?
X è un segno grafico ed è un lavoro che nasce a luglio 2020. Uno dei miei corti era in concorso al Lago Film Festival ed ero stato invitato da Alfredo Agostinelli a seguire un workshop con i curatori del Cruising Pavillion della Biennale 2018. Il workshop prevedeva un confronto tra la piccola cittadina di Lago e il festival di cinema indipendente. Sullo sfondo, la figura del lago, nella sua immagine patinata da cartolina ma anche nella sua realtà più inquietante intrisa di leggende.
Ho una processualità lunga, avendo io bisogno di molto tempo per calarmi e per poter vedere le cose in un determinato modo. Questo perché odio il banale e ciò che non è ragionato o ricercato. Ero quindi immerso in un processo assolutamente osservativo in linea con la mia ricerca e il mio progetto: l’idea di base era installare delle camere di sorveglianza, lungo il perimetro del lago per capire ciò che vi succedeva. Iniziavo così la residenza di un anno. La mia modalità prevede che io divida il tempo in modo da poter entrare e uscire dalla realtà, alternando periodi di immersione a fasi di allontanamento per riequilibrare la mia prospettiva. Ero partito a novembre per 3-4 giorni e così ogni mese sono tornato fino a febbraio per concludere poi il lavoro a maggio.

Ad un certo punto, nell’osservare il lago, capisco che vi è anche una sorta di contraltare. Muovendomi in mezzo alla comunità vengo portato verso Doriano, un ragazzo che vive in una dimensione a lui molto stretta. Sembra diverso rispetto al contesto chiuso e diffidente della provincia ma resta a tutti gli effetti un figlio della provincia. È una diversità che si allontana e si attrae, perfettamente calata, come perfettamente avulsa. Mi sono trovato quasi ad aprire una matrioska dopo l’altra: il lago cadeva dentro Doriano che cadeva dentro la realtà che cadeva a sua volta dentro altro. Di questo progetto ho tanto apprezzato il coinvolgimento con Doriano, si è innestata una modalità secondo cui io non stavo più facendo un lavoro su di lui ma stavamo facendo un lavoro insieme.
X è il mio primo lavoro in cui c’è molto parlato, avvicinandosi quasi ad un documentario. Allo stesso modo non c’è una definizione di una narrativa precisa che arrivi in un punto calato ma c’è un veicolarsi del tempo all’interno di un racconto che appare sfasato, molto goffo, cucito su misura per Doriano, mentre racconta, per esempio, della sua vita da sarto o del lavoro in un lanificio della zona. X in effetti è stato un percorso abbastanza diverso, un primo step verso una maniera nuova di ragionare sul mio lavoro.
A: In X abbiamo notato la tua volontà di offrire uno sguardo “altro”, disincantato, più cupo e inquieto, rispetto alla canonica immagine del lago. La provincia, in cui il tempo è scandito da tempi ciclici e ripetitivi, fa da sfondo a molte tue opere? Cosa rappresenta per te la provincia?
Ho sentito dire che “la provincia ci ha mangiato”. Un po’ tutti noi siamo figli della provincia, che non ha per me un’accezione necessariamente negativa. Siamo figli di luoghi che in qualche modo ci respingono e ci trattengono. Io sono convinto che se non fossi nato qui, in un determinato contesto, avrei un’altra modalità di visione delle cose. Per me poi la provincia è essere figli di qualcosa, identificarsi con quel qualcosa. Non per forza ci fa del bene, ma ci custodisce e ci tiene lì. Nei miei lavori la provincia c’è perché io seguo un percorso visivo che non ricami ma osservi la realtà con occhi diversi. Riguardo al ritmo ciclico del tempo della provincia, secondo me questa è la bellezza del poter osservare senza dover comporre qualcosa ogni volta! Ci hanno insegnato che, se vediamo qualcosa, dobbiamo riuscire a partire da un punto A per arrivare ad un punto B ed in mezzo costruirci qualcosa. E questo può essere vero come no, dipende dal registro all’interno di ciascuno di noi cosicché quello che per me è un ciclo finito per te potrebbe essere un ciclo mai iniziato: ecco, la provincia è il collettore di tutto questo. E nei miei lavori lascio che il tempo non abbia mai fine.
A: Un tema chiave dei tuoi video è la marginalità. Basti pensare ad Elisa, ragazza non vedente copilota di rally (Circuito) o all’immigrato senegalese Papis impiegato nei bagni Alberoni di Jesolo (Spazio Morto) o a Renzo, tuo padre, costretto a convivere di notte con la macchina per la dialisi (Harmony) o a Doriano, omosessuale e artista in un paesino di poche anime (X). Quelli citati sono tutti esempi virtuosi di persone che vivono attivamente la propria specifica condizione?
Non credo che il lavoro su Papis, Elisa e su mio padre siano degli esempi virtuosi, non c’è l’esaltazione di nessuna condizione per dire che qualcuno è migliore di qualcun altro. C’è solo una modalità di affacciarsi sul reale e renderlo visibile.

A: Abbiamo notato che negli ultimi corti hai privilegiato protagonisti che si raccontano: ne emerge un taglio più personale, intimo e umano. Come mai questa scelta? È una cosa su cui vorrai insistere o consideri questi lavori delle eccezioni?
Posso anticiparvi che c’è un lavoro in corso ma non posso ancora rivelarvi molto. Il progetto prevede un racconto attorno alla tematica del trauma nel campo psichiatrico, e l’idea è di mettere i discorsi al centro senza quasi nessuna immagine.
Doriano rientra nella mia ricerca in una modalità che non è un dialogo-intervista quanto piuttosto un racconto – flusso di coscienza. In tale situazione non hai margini ben precisi entro cui stare e quindi la realtà ti viene incontro rompendo paletti e aprendo carreggiate sempre più ampie.
Il lavoro che inizierò a breve a Torino, ad esempio, è un lavoro più installativo, me lo immagino più fermo, cioè fatto di sguardi che vanno su una realtà che è talmente tanto ampia, che riuscire a incanalarla è difficilissimo. Porta Palazzo a Torino è un quartiere bellissimo, ospita uno dei mercati più grandi d’Europa. Io entrerò in quel contesto da completo estraneo e, anche se rimanessi lì 6 anni, non riuscirei a capire totalmente, immaginatevi avere due settimane per estrapolare qualcosa! In questo caso la ricerca si ferma alla modalità con cui io entro in quella realtà, che magari poi potrà aprire delle porte verso una visione più ampia.
Con Doriano è stato tutto molto naturale, non ho pensato “Ora mi siedo davanti ad una persona e faccio delle domande a tavolino”. Ci siamo trovati due volte e abbiamo parlato insieme. In X la camera non ha quasi valore, è secondaria, lui era spesso sfocato perchè a me non interessava mettere a fuoco la sua figura. Il fuoco era un punto quasi casuale. Se avessi cercato la messa a fuoco perfetta in ogni istante, avrei perso Doriano.
A: In Spazio Morto (2016) immortali la routine di un immigrato senegalese, sospeso tra orto, capanna e lavoro in spiaggia. Oggi avresti girato il video nello stesso modo? Gli avresti dato voce, facendogli raccontare la sua realtà a parole?

No, non potrei rifarlo. Lì il discorso non c’era, in 8 mesi io e Papis abbiamo costruito un rapporto di un certo tipo in cui lui mi portava a vedere delle cose, facendomi entrare nella sua realtà. Tutti i dati che ho raccolto su di lui non me li ha nemmeno raccontati lui. Papis non aveva la necessità di dire delle cose e io non volevo forzare il racconto.
Harmony descrive la routine di tuo padre Renzo, 70 anni, costretto a convivere la notte con la macchina per la dialisi. Il video offre il fianco a riflessioni circa la precarietà della vita, l’importanza di vivere ogni istante del tempo che si ha a disposizione, e il legame indissolubile tra vita e malattia. Com’è stato girare un corto che ti tocca così da vicino e questo lavoro ti ha portato a guardare tuo padre con occhi diversi?
Il lavoro Harmony, su mio papà, è uno di quelli a cui tengo di più: mai avrei pensato di farlo. Ho un rapporto talvolta conflittuale con i miei genitori che, avendo 45 anni in più di me, sono portatori naturalmente di una visione diversa dalla mia. È successo che, mentre stavamo seduti in auto, lui iniziava a dire delle pillole e io le raccoglievo. Il lavoro è stato un pugno sullo stomaco. Con mio padre ho sempre avuto un rapporto unico nel suo genere. La differenza d’età e il vissuto diverso inevitabilmente si fanno sentire. È innegabile che ci siano anche visioni diverse: il percorso che sto facendo, per esempio. Nella provincia veneta, l’idea di fare l’artista non è così scontata e naturale, anche se ora i miei genitori iniziano a capire.
Quando ho vinto la residenza di GAM e Fondazione Spinola Banna la tematica era perfetta. Parlando con la curatrice, Caterina Benvegnù, ho realizzato che la tematica che stavamo affrontando, il diario e la costruzione di un tempo giornaliero scandito, si sposava perfettamente con la storia di mio padre, costretto a scandire il proprio tempo seguendo il ritmo della macchina della dialisi. Mio padre è la provincia, è quell’idea di restare aggrappati ad un tempo solido, che restituisca i frutti prodotti. Quando la tua immagine viene in qualche modo rotta, interrotta o frammentata da qualcosa che non puoi controllare, tutto viene rimesso in discussione.
Tra l’altro, per Harmony (2019), sto collaborando con un curatore (Nicolas Ballario, curatore del settore arte di Rolling Stone Magazine, ndr) per portare l’opera nei maggiori musei italiani.
A: A breve partirai per Torino per una nuova residenza, quali progetti hai in serbo per futuro e quali sono i tuoi sogni?
Per quanto riguarda i miei impegni futuri, a Torino andrò a fare una residenza prevista inizialmente a marzo. Sarò nel quartiere multietnico di Porta Palazzo e il progetto originale voleva abbracciare le storie di persone su piani diversi del condominio per poi unirle insieme. Il Covid ha cambiato totalmente l’humus umano, per cui la mia attenzione si è spostata su come il movimento delle persone sia cambiato, su come i flussi di persone siano estremamente rarefatti in un contesto come quello del mercato che è luogo di scambi e incontri per antonomasia. Dal punto di vista tecnico, sto utilizzando la photo trap, un dispositivo utilizzato anche per immortalare gli animali.
E noi facciamo i nostri migliori auguri a Daniele, ringraziandolo di cuore per la disponibilità con cui ha risposto al nostro invito!