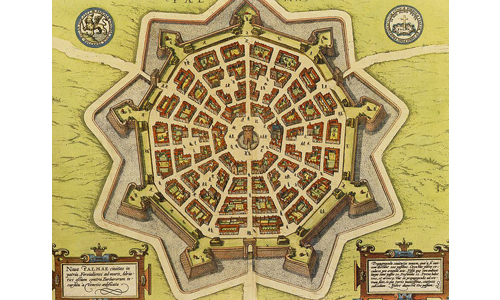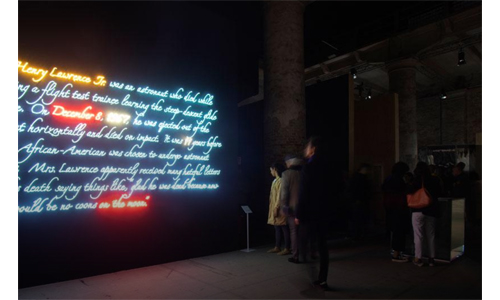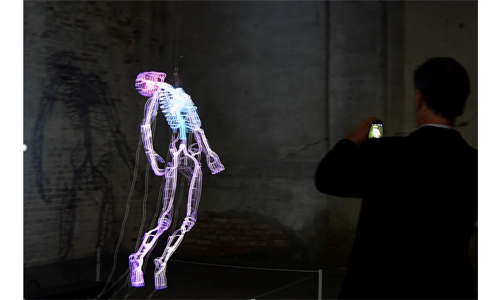L’Italia è il Paese delle perenni lamentele, delle stupide polemiche e dell’incapacità di connettere il cervello alla bocca. La Ferragni colpisce ancora e di nuovo fa scandalo, ma mentre il mondo del web guarda a lei con indignazione non si accorge che, forse, sta succedendo molto di peggio. Perché? Scopriamolo insieme.
Dopo gli Uffizi, il Salento e la Sardegna, Chiara Ferragni conquista di nuovo Venezia.
Un anno fa camminava sul red carpet del Festival del cinema – che si svolge nella città lagunare – per sponsorizzare il suo docu-film, Chiara Ferragni-Unposted, quest’anno, invece, ha ricevuto il Leone d’oro per l’impegno che ha dimostrato durante l’emergenza COVID e nella ricerca di far riprendere l’economia del Paese puntando sulla cultura. Ovviamente questa premiazione non è andata giù ai più che hanno visto solo l’ennesima trovata pubblicitaria di una manifestazione che, privato dalla copertura mediatica di un tempo a causa della pandemia, aveva bisogno di far parlare di sé. Ma è indubbio che l’impegno dell’imprenditrice digitale sia stato importante, come quello di tanti altri, per raccogliere fondi necessari alle strutture mediche pubbliche, per sensibilizzare le persone sull’importanza dei dispositivi di protezione e a spingerle a spostare il proprio sguardo su attività più culturali e meno mondaiole.
La polemica, però, non si è fermata dopo uno dei suoi post.
Gli organizzatori del Festival, come quelli di tanti altri eventi di questa portata, offrono ai proprio ospiti una gita per la città in cui si svolge, appunto, l’evento (se ve lo siete perso su Instagram i Pinguini Tattici Nucleari, Shade, Elettra Lamborghini e tanti altri hanno condiviso nelle stories le gite che hanno fatto nel Salento grazie alla partecipazione al Vodafone Battiti Live). In questo caso Chiara ha avuto il piacere di salire su Scala Contarini del Bovolo, un piccolo gioiello tra le calle di Venezia, dove ha posato per una foto in cui, ahimè, metteva un piede sullo zoccolo dove poggiano le colonne del parapetto. I veneziani, e non solo, si sono lanciati contro di lei all’urlo di Hai rovinato Venezia !. Seriamente? Un piede su un parapetto ha rovinato la città? E le lavatrici, le vespe e le macchine (sì, perché hanno tirato fuori anche quelle!) che vengono portate alla luce ogni volta che si draga un canale non rovinano Venezia? I turisti che si tuffano in Laguna (e li ammiro per il loro coraggio visto lo schifo che c’è nell’acqua) e che lanciano oggetti dai ponti o che scambiano la Galleria Marciana per un WC? I turisti e non, che fanno fare ai bambini le foto sui leoni di San Marco rischiando di romperli o rovinarli? Loro non rovinano la città, ma un piede su un parapetto sì?


Complimenti per le vostre priorità! E sì, sono cattiva sul discorso perché mi sembra assurdo che le persone non riescano ad andare oltre, a vedere dove stanno i veri problemi del mondo dell’arte. E non parlo del piede della Ferragni, ma dell’ipocrisia che ormai si sta impadronendo anche delle alte sfere, degli organi competenti alla tutela del nostro Patrimonio.
E, tranquilli, vi porto degli esempi illustri. Il primo è datato 23 luglio 2020: a Lecce, nella piazza principale, si svolge la sfilata in cui viene presentata la nuova collezione di Dior, ispirata alla bellissima Puglia. La scelta non è assolutamente casuale: la famiglia di Maria Grazia Chiuri, la prima donna a dirigere la famosa casa di moda francese, è originaria della città e l’ha voluta omaggiare presentando proprio qui la nuova linea Cruise che richiama la tradizione della sua Terra.


Con l’aiuto dell’artista Marinella Senatore la piazza è stata riempita da più di 3.000 led, sistemati su strutture autoportanti, simili a quelle utilizzate per le feste di paese. Ad allietare la serata e accompagnare la sfilata vi era la pizzica, la musica tradizionale, canti e balli popolari. A completare il tutto, Giuliano Sangallo, voce dei Negramaro, al termine della serata ha eseguito Meraviglioso.
L’evento ha avuto un grande successo ed è stato accolto positivamente dalla critica e dall’ambiente storico-artistico, come un modo per riportare alla luce la tradizione di un luogo così ricco di storia e il rispetto per i beni che si affacciano sulla piazza. Ovviamente c’è chi si è lamentato in quanto, in un periodo come questo, non si deve guardare a sciocchezze come la moda, perchè sono stati probabilmente danneggiati degli elementi architettonici a causa di strutture che di sicuro non erano autoportanti e anche chi ha inneggiato allo scandalo dell’appropriazione culturale e così via…
Tutte osservazioni inutili e fatte unicamente per criticare. Sarà stato un evento superficiale e inappropriato per il periodo che stiamo vivendo, ma ha portato lavoro ad albergatori e ristoratori che fino a quel momento erano in crisi nera, inoltre nessuno di questi leoni da tastiera era presente e quindi non hanno potuto controllare in che modo si sorreggessero le strutture. Non possiamo che fidarci dell’artista che ha pensato all’installazione, ma, soprattutto, se non fossero state autoportanti, come li avrebbero sistemate in poco meno di tre giorni? I danni per un’installazione e disallestimento così rapidi sarebbero stati evidentissimi. E poi appropriazione culturale di cosa? Lei è pugliese, quindi ha solo elogiato la sua cultura natia.
Tante lamentele su tutto questo e non sul fatto che la Sovraintendenza dei Beni Culturali non ne sapesse nulla! Infatti, un paio di giorni dopo la sfilata esce la notizia riguardo al fatto che coloro che devono tutelare e controllare i Beni Culturali della zona non si erano accorti che lì ci sarebbe stata una sfilata. Dicendo prima che la richiesta non era mai arrivata e successivamente che era arrivata il 14 luglio, quindi meno dei 30 giorni previsti per legge. La domanda sorge, quindi, spontanea: perché, sapendolo, non si è fermata la manifestazione? Perché si è preferito parlare dopo, quando il danno era già fatto, piuttosto di fermare i lavori? Sarebbe stata una cosa sensata se il vero scopo era salvare il Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Invece si è preferito correre il rischio e mandare poi una multa.
In sordina, invece, è passata la sfilata di Dolce&Gabbana del 2 settembre a Palazzo Vecchio. La nota casa di moda milanese ha presentato in questi giorni una nuova collezione ispirata al Rinascimento (il Rinascimento non c’è stato pure a Milano?) e che propone stampe e ricami che hanno come soggetto il giglio fiorentino (non è appropriazione culturale?). La sfilata, a differenza di quella di Dior, ha bloccato il Palazzo, che ricordo essere la sede di un museo ed essere di fronte a Piazza della Signoria, che, quindi, ha subito dei blocchi lei stessa, per ben 13 giorni. Tempo che è servito per allestire la sala con la passerella e per organizzare la cena di gala nella Sala dei Cinquecento. Giorni in cui i visitatori non hanno potuto ammirare le opere o passeggiare per una delle piazze più belle di Italia.


E se Dior ha cannato con le tempistiche, ma ha pagato la salata multa, e la Ferragni ha pagato, come hanno più volte spiegato Schmidt e gli addetti alle entrate economiche degli Uffizi, la somma dei biglietti rimasti invenduti durante la sua visita, D&G hanno ricevuto un trattamento alquanto…economico. I tredici giorni di occupazioni gli sono costati solo il 50% della normale quota di affitto del suolo pubblico, l’accesso e lo scarico in ZTL sono stati gratuiti, l’esenzione dal pagamento del lavoro straordinario della Polizia Municipale, che doveva organizzare la viabilità della zona, e la partecipazione gratuita del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha allietato gli ospiti all’inizio della serata.
E la domanda che vi pongo è: veramente ci indigniamo per un piede su un parapetto, che forse ha visto ben di peggio, quando chi deve proteggere il nostro Patrimonio preferisce intascare una multa piuttosto di bloccare un evento per verificare le norme di sicurezza o piegarsi al volere di una maison, invece, di pensare ai turisti che vogliono accrescere il proprio bagaglio culturale o ai cittadini? Seriamente, la Ferragni è la nostra priorità e non un museo chiuso per due settimane? Veramente ci indigniamo di più per il fatto che i musei siano chiusi a causa del COVID e di mancanza di personale, invece di pensare che sia una vergogna che venga chiuso per un evento riservato a pochi?
Forse è il caso di rivedere le nostre priorità..
Fonti:
–https://www.elle.com/it/showbiz/gossip/a34022660/chiara-ferragni-news-leone-doro-venezia/
-A. de’Navasques, Dior sfila a Lecco con la collezione Cruise 2020. Con un intervento di Marinella Senatore, https://www.artribune.com/progettazione/moda/2020/07/dior-cruise-2021-lecce/
-F.Giannini, Firenze, Palazzo Vecchio regalato a D&G, https://www.finestresullarte.info/opinioni/firenze-palazzo-vecchio-regalato-a-dolce-e-gabbana