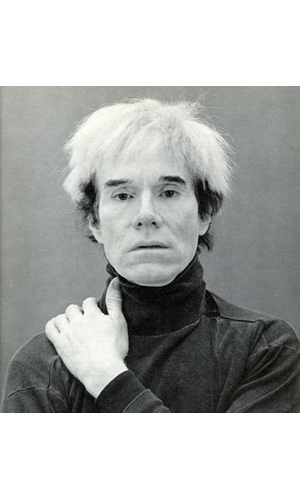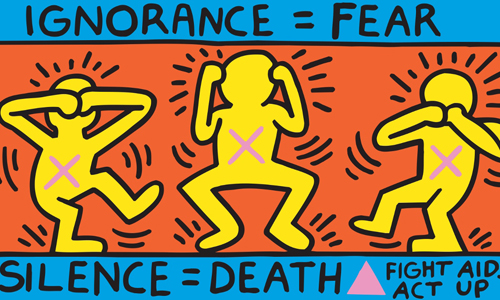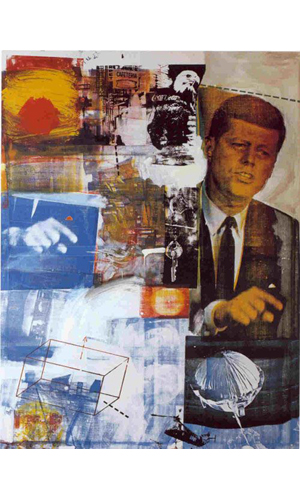Mentre la natura ci avverte che il nostro pianeta ha le ore contate, anche l’arte cerca di fare la sua parte rendendosi pedina fondamentale per parlare di cambiamento climatico e necessità di ridimensionamento.
Sono passati ormai decenni da quando Joseph Beuys faceva parlare di sé grazie alle sue performances a sfondo sociale e politico. Da ciò possiamo dedurre che la sensibilizzazione delle persone sul tema ambientale non è un argomento nuovo per l’arte contemporanea, eppure sembra che la musica si debba ripetere: nonostante passino gli anni e le decadi, la nostra natura è sempre più in difficoltà per quanto si cerchi di apportare dei cambiamenti nel nostro stile di vita. Macchine elettriche, giardini verticali e quant’altro non bastano, ci si presenta di fronte un mondo sofferente dove smog e consumo di risorse naturali diventano sempre più un problema insostenibile.

L’emergenza climatica è ormai argomento quotidiano e Climate clock, la nuova opera di Gan Golan e Andrew Boyd ci dà un ultimatum. Quanto tempo ci rimane? A detta degli scienziati poco ed è questo che ci vogliono ricordare i due artisti con il loro countdown, il quale inesorabilmente segna lo scorrere del tempo. Per la settimana della lotta al cambiamento climatico a New York, il monumentale orologio è stato visibile nella Grande Mela, dove ha preso temporaneamente il posto dell’opera di Kristin Jones e Andrew Ginzel Metronome (un’opera d’arte che segna l’inesorabile passare delle ore durante le giornate segnalato in secondi), tra i grattacieli di Union Square. Questo è servito a rendere consapevoli le persone, che alzando lo sguardo tra gli imponenti edifici, potevano rendersi conto del fatto che il tempo sta per scadere, difatti gli anni che mancano al cosiddetto punto di non ritorno sono meno di 8. Il primo gennaio 2028 è considerato, dagli esperti, il giorno in cui non si potrà più tornare indietro, se le emissioni di monossido di carbonio continuassero a rimanere tali. L’inesorabile conteggio è basato su una serie di calcoli recentemente condotti dall’ONU, i quali cercano di rispondere e fare chiarezza su una domanda: quanto tempo ci rimane? Secondo questi studi, nel caso in cui le emissioni di C02 rimarranno invariate, il già citato capodanno del 2028 segnerà il momento in cui le temperature subiranno un innalzamento di 1,5°, che corrisponde alla condanna per il nostro pianeta.

“L’umanità ha il potere di aggiungere tempo all’orologio, ma solo se lavoriamo collettivamente e misuriamo i nostri progressi rispetto a obiettivi definiti”, questo si legge sul sito ufficiale del Climate clock, che rimarrà in funzione fino al fatidico giorno; sulla pagina si possono vedere non solo il conto alla rovescia e la percentuale con cui le fonti rinnovabili si stanno sostituendo a quelle inquinanti, ma offre anche la possibilità di portare nelle proprie case e nelle proprie città questa condivisa opera. Non ci deve stupire che essa sia così pubblicamente fruibile, poiché lo scopo è quello di raggiungere più persone possibili attraverso tutti i mezzi che si possono sfruttare in quanto tutti noi siamo coinvolti sia come causa, ma possiamo essere parte della soluzione. Come ben sappiamo infatti l’arte pubblica non ha solo lo scopo di abbellire e rendere più piacevoli le città, ma anche quello di rendere più virale e mondiale possibile un messaggio, che esso sia sociale, politico, economico o ecologico, come in questo specifico caso. L’orologio molto chiaramente urla al mondo l’emergenza in cui siamo coinvolti e in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte. “The Earth Has a Deadline”, la Terra ha una scadenza, si legge sotto l’opera ed è chiaramente un tipo di arte poco confortevole quella che si presenta ai nostri occhi, una tipologia di arte reale, senza fronzoli o vana speranza. Un semplice messaggio chiaro che non punta a passare astrusi e astratti concetti filosofici, ma bensì fatti e dati che dovrebbero preoccuparci e dovrebbero farci riflettere su ciò che ogni giorno facciamo e come agiamo in questo nostro breve lasso di esistenza, il quale lascia l’impronta per ciò che verrà. L’arte, che per molti è semplice diletto oppure ancora peggio sovrastruttura inutile, ancora una volta si schiera in prima linea per comunicare, per essere parte del mondo, reale e tangibile.

Qualche domanda ce la dobbiamo porre. Qualche risposta la dobbiamo assolutamente cercare. Mentre state leggendo questo articolo i secondi e i minuti continuano inesorabilmente a calare, lasciando che il tempo ci sfugga dalle mani non riusciremo mai a salvare non solo la Natura, ma anche noi stessi.
Vi lasciamo il link del sito, dove potete conoscere meglio18 il progetto e fare pubblicità ad una buona causa: https://climateclock.world