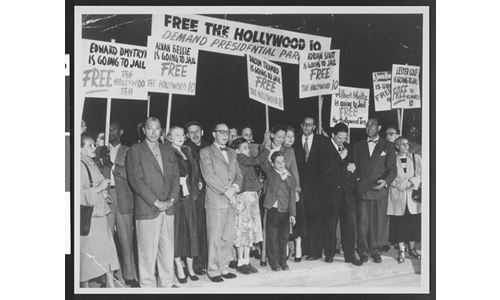Casa è il luogo in cui ci sentiamo più al sicuro ed è quello che ci rappresenta maggiormente. Anche nel mondo cinematografico, lo spazio casalingo può nascondere grandissime curiosità sui personaggi che lo abitano.
Gli ultimi mesi sono stati difficili per tutti. Non vediamo l’ora di poter tornare fuori. Una volta, risucchiati nel vortice della quotidianità frenetica, non si vedeva l’ora di poter star a casa per vari giorni. Stare perennemente accerchiato dalle stesse mura ci fa sentire un po’ come in una cella. Ormai la conosciamo a memoria, scopriamo piccoli dettagli che prima non consideravamo. Abbiamo imparato ad andare oltre il semplice guardare. Quello che stiamo riuscendo a fare è sviluppare quella tecnica del vedere che mai abbiamo esercitato prima di adesso. Capiamo che gli oggetti che ci circondano non sono lì per caso, preesistenti prima del nostro arrivo. Ogni cosa è lì perché l’abbiamo messa noi. Così qualsiasi oggetto, che sia una penna scarica o un divano con le doghe rotte, diventa tessera di un puzzle complesso e lungo da costruire. Solo unendo tutti i pezzi scopriremo che la figura creata non è altro che la nostra persona.
La casa diventa il luogo dove la nostra anima si rifugia dalle intemperie della natura. È il nostro ventre materno, in cui tutte le cattiverie e le atrocità della vita rimangono fuori dalla porta d’ingresso. A casa nostra non abbiamo paura, ci sentiamo protetti. Dentro, non esiste la distinzione tra ciò che è normale e ciò che non lo è. I nostri tabù e i nostri segreti più intimi non si nascondono, anzi, si riflettono in tutto l’arredamento. Nel cinema, l’ambiente casalingo è sempre stato lo specchio riflesso della psicologia dei personaggi e chi lavora nel cinema lo ben sa. Il rapporto tra regista e scenografo lo si può descrivere metaforicamente come un continuo dialogo tra un paziente che legge molti libri di psicologia e il suo psicologo: per quanto il regista possa saperne di come la psicologia funzioni è solo grazie al lavoro dello scenografo che tutto questo diventa pratica reale.


Norman (Anthony Perkins) in Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
Ad Hitchcock dobbiamo ringraziare quella sua sensibilità nella costruzione dei personaggi, attorniati da storie che i critici di adesso definirebbero, senza andare oltre, ”storie commerciali”. “Psycho”, a differenza di tutti gli altri suoi film, non crea la famosa suspense attraverso movimenti o azioni che ci accompagnano, bensì attraverso il dialogo tra la ladra Marion e il pazzo Norman. In una delle scene più famose, dove Norman racconta del rapporto con la propria madre, Hitchcock non cerca di enfatizzare il lato alienato di Norman attraverso inquadrature spettacolari. Decide, invece, di usare due primi piani semplici, ma che hanno un peso importante. Egli riesce a creare due spazi completamente opposti all’interno della stessa stanza: da una parte abbiamo Marion. Tutte le linee sono simmetriche e parallele. È un primo piano qualunque, da manuale diremmo. Ciò che rende spettacolare questa inquadratura è il rapporto con il suo opposto, ovvero Norman: qui tutto è confusionale, il primo piano è ripreso dal basso, mostrando i quadri storti e persino il soffitto; gli uccelli appesi creano un senso di confusione e di caos. Norman è pazzo, lo capiamo benissimo già dalla figura di Anthony Perkins. Quello che Hitchcock fa è spiegare da dove derivi questa pazzia. Un dialogo così normale sulla madre viene stravolto dalla confusione delle mura dietro di lui.
L’architettura di un luogo può anche essere trasformato, divenire scatola dei sogni e delle fantasie. L’ambiente può essere trasformato nelle visioni personali del personaggio. Può essere la visione di un anziano signore, di un innamorato…persino di un adolescente fuori dal comune. L’ossessione di Stanley Kubrick per la precisione del dettaglio è un esempio di come l’ambiente sia fondamentale nella costruzione di un film. “Arancia Meccanica” punta esplicitamente su questo fattore, costruendo e plasmando un mondo sotto gli occhi di un adolescente accecato dall’egoismo titanico. Percorrendo la pubertà violenta e sessuale, il mondo che circonda Alex è invaso da peni disegnati sui muri, affreschi di donne intente a masturbarsi, gli oggetti si plasmano sotto la sua percezione distorta: tavolini e fontane di latte prendono le sembianze di donne nude, peni giganti diventano armi per giocare e uccidere, maschere falliche diventano oggetti iconici del film. Tutto questo modo di vedere permette ad Alex di giustificare le rapine, le violenze e gli stupri, pensando che la realtà che vede sia unica ed eterna. L’ultraviolenza è l’atto quotidiano di un mondo che gira attorno alla poesia dell’erotismo.

(Arancia Meccanica, Stanley Kubrick, 1970)

buco, Galder Gaztelu-Urrutia, 2019)
Ma in un periodo come questo è difficile pensare alla propria casa come un rifugio, bensì come una prigione. La casa si trasforma e diviene la prigione corporea della nostra anima, come direbbe Platone. Il fuori diventa il paradiso che sogniamo. Dentro le mura ciò che ci spaventa è scoprire la vera natura, quella ostile, quella che fa di tutto per renderci la vita impossibile. Una visione romantica potremmo dire. I film sull’isolamento, sull’impossibilità di uscire se non attraverso gesti disumani ma naturali per sopravvivere. Ultimo esempio uscito è sicuramente “Il buco” dove la vera natura dell’uomo non è la fede religiosa, tanto meno la compassione. La vera ragione di vita non ha senso, esistiamo solamente perché dobbiamo sfamarci e non ci importa degli altri. Quando si sopravvive si è uno contro il resto.
La casa, in conclusione, è sia il ventre materno sia la cella claustrofobica. In ogni caso, qualsiasi sia la visione del personaggio, l’ambiente, la scenografia è riflesso di tutto quel pensiero e il cinema diventa un modo più godibile di osservare i casi clinici, ovvero le nostre storie.
Fonti:
-L. Falqui e R. Milani, ‘L’atelier naturale: cinema e giardini’, in Il cinema e le idee, vol. 9, CADMO, 2007
-G. Rondolino e D. Tomasi, Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi, UTET, 2016
-S. Iommi, Appunti per un’analisi dell’ambientazione nel film, Vecchiarelli, 2012.