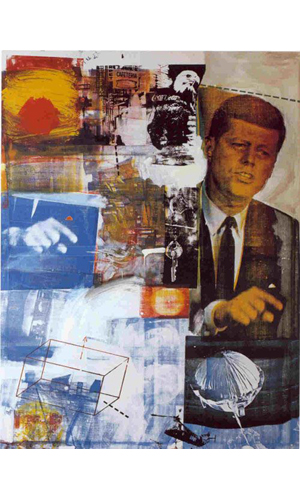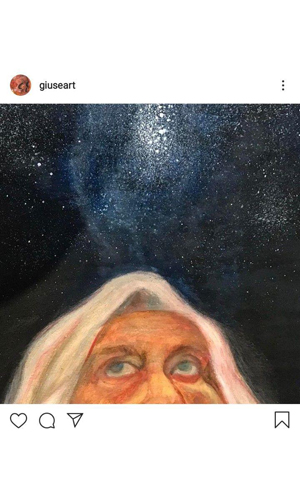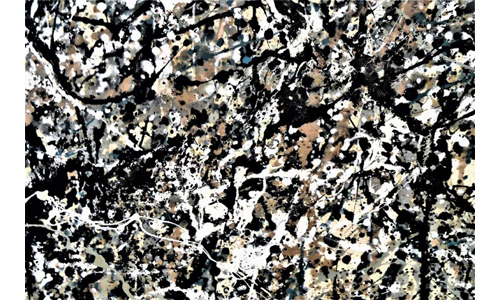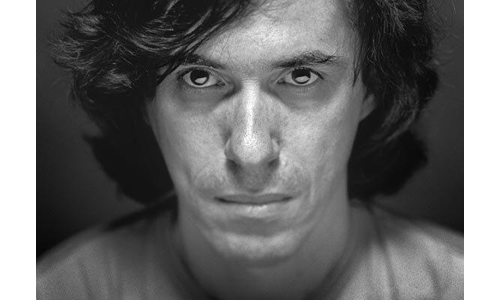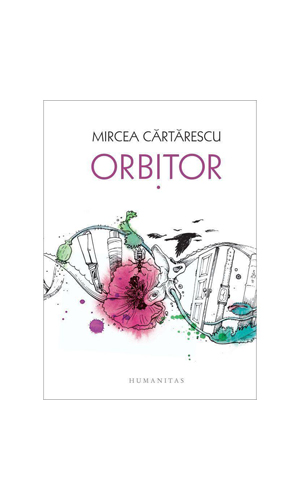Millet rappresenta nelle sue opere un lavoro povero e faticoso, che spezza la schiena e che molto spesso è sinonimo di miseria. Eppure, osservando i suoi quadri, non possiamo fare a meno di vederlo come il più poetico e dignitoso di sempre.
Ci siamo appena lasciati alle spalle il 25 aprile e la Festa della liberazione italiana dal nazifascismo e con la nuova settimana ci avviamo verso un’altra importante ricorrenza. Stiamo parlando ovviamente del primo maggio, giorno dedicato ai lavoratori. Tale festività viene celebrata non solo in Italia, ma in vari paesi del mondo e ha lo scopo di ricordare le lotte che hanno portato all’attenzione i diritti in tale settore, quali la riduzione della giornata lavorativa, la paga minima del salario e così via. La lotta e la conquista di tali diritti risale all’Ottocento a seguito della rivoluzione industriale che ha catapultato la società verso l’epoca contemporanea e la conseguente nascita e sviluppo delle fabbriche e quindi della classe operaia, inizialmente brutalmente sfruttata e costretta a lavorare in condizioni ignobili.


La questione in quegli anni è talmente rilevante che coinvolge anche le arti: noti sono i grandi classici letterari come Oliver Twist di Charles Dickens e Rosso Malpelo di Giovanni Verga, i quali pongono la loro attenzione sul lavoro minorile, ma sono ancora tanti gli esempi che si possono fare. Anche l’arte non rimane esente dal dovere di mostrare tali condizioni e nel corso del XIX secolo, infatti, vediamo i lavoratori diventare protagonisti in molte opere che faranno poi la storia. Tra i pittori che si sono dedicati maggiormente a questi temi, abbiamo Jean-François Millet, artista francese considerato tra i massimi esponenti della corrente del Realismo. Nato in un piccolo paese della Normandia nel 1814 da una famiglia di poveri contadini, riesce comunque a trasferirsi a Parigi per studiare all’École des Beaux-Arts, esordendo senza successo al Salon del 1839. Nei successivi anni si trasferisce a Barbizon, dove viene fondata una scuola di pittura, un luogo in cui Millet e altri pittori possono dedicarsi a un nuovo tipo di arte, lontana dai valori accademici. Distante dalla città e dagli sviluppi industriali, il pittore accoglie le sue umili origini contadine e inizia a raccontare, attraverso le sue opere, le condizioni e le vite di coloro che abitano e lavorano la campagna.
Ecco allora quadri come il Seminatore (1850), l’Angelus (1857) e il più noto, le Spigolatrici (1857); in tutti i suoi lavori le figure rappresentate appaiono solenni, Millet gli affida una dignità quasi eroica, diventando simbolo di emancipazione. Zappatori, piantatori di patate, contadini e pastorelle: il pittore racconta la vita agreste con una vicinanza affettiva, analizzando semplicemente la loro quotidianità, modesta ma faticosa, in tutti i momenti della giornata, dal mattino alla sera. A differenza di altri pittori del suo tempo, appartenuti alla sfera del realismo, le opere di Millet sono tuttavia prive di un’aperta denuncia sociale, fatto che gli valse tra l’altro alcune critiche, ma sono frutto dell’intento di mostrare il mondo rurale e i suoi valori, legato a un contatto maggiore con la natura ed estraneo al disordine rivoluzionario della città. Nonostante ciò, è indubbio che questi quadri hanno avuto una grande importanza sia dal punto di vista pittorico, influenzando pittori successivi, sia dal punto di vista delle tematiche, mettendo in luce le condizioni di vita di chi lavora i campi.


Dall’Ottocento in poi molte sono le conquiste che hanno riguardato i diritti dei lavoratori ma dobbiamo ricordarci, e il primo maggio serve anche a questo, che non dobbiamo mai smettere di combattere per essi, e forse oggi ancora di più è forte questa necessità, poiché, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, la salute e la sicurezza del lavoratore deve rimanere in primo piano e l’arte, come ha sempre fatto e sempre farà, può contribuire in tale senso.
Fonti:
– R. Rosenblum, H. W. Janson, L’arte dell’Ottocento, Palombi, 1986