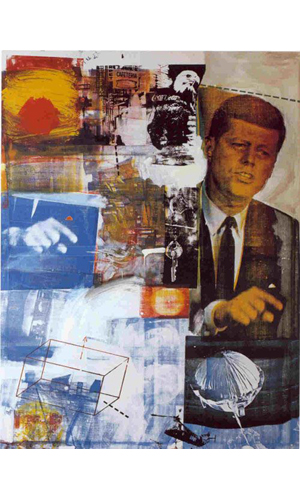“Maschile? Femminile? Ma dipende dai casi. Neutro è il solo genere che mi si addice sempre”.
Con queste parole oggi vi portiamo alla scoperta di Claude Cahun, pseudonimo di Lucy Renée Mathilde Schwob, artista, fotografa e scrittrice francese tra le massime esponenti del surrealismo.
Nata a Nantes nel 1894 sin da subito si appassiona alla scrittura, alla fotografia e alla recitazione, firmando i suoi primi lavori adoperando diversi pseudonimi, da Claude Courlis a Daniel Douglas fino a optare per quello definitivo che l’ha resa celebre fino ai giorni nostri. Appena quindicenne si lega sentimentalmente con la sorellastra Suzanne Malherbe, fotografa conosciuta col nome di Marcel Moore con cui trascorrerà il resto della sua vita. Insieme a quest’ultima, negli anni Venti, si trasferisce a Parigi ed è in questa occasione che l’artista entra in contatto con le figure centrali del movimento surrealista, André Breton (autore del manifesto nel 1924), Tristan Tzara, Salvador Dalì, Man Ray e molti altri. La fotografia si lega al movimento pittorico non tanto per lo stile o il linguaggio formale utilizzato, quanto per l’approccio concettuale con la quale vengono trattati i temi e i soggetti raffigurati. Ai fotografi surrealisti, infatti, non importa la ricerca di una tecnica precisa dell’esecuzione ma, come per i colleghi pittori, prevale il concetto di automatismo che viene spiegato da Breton nel manifesto del movimento.


Lo scatto non è meditato né sapientemente orchestrato ma è il risultato del caso, il quale ci ricollega all’altro concetto fondamentale della poetica surrealista, quello dell’objet trouvé, ovvero un qualcosa che l’artista trova casualmente girovagando ma che diventa opera significante. Le immagini sono quindi stranianti, spesso volutamente sbagliate ed espressione di una dimensione che ha a che fare con la psiche umana. Tra i rappresentanti del gruppo Cahun trae più ispirazione da Cecil Beaton, fotografo di moda la cui caratteristica è quella di mettere in scena delle immagini allusive che rimandano ad atmosfere trasognanti. Protagonista indiscussa dei suoi scatti è lei stessa, la quale scinde il suo corpo in più identità affrontando in maniera precoce, rispetto al tempo, il tema della sessualità e dell’identità di genere.
La fotografa mette in scena una vera e propria trasformazione di sé stessa andando oltre la semplice differenziazione tra femminile e maschile e ponendo in essere quasi una sorta di body art ante litteram, in quanto attraverso questa pratica attua una vera e propria verifica e oggettivazione del suo corpo, diventando pioniera di una tematica tutt’oggi viva e fortemente dibattuta.Claude Cahun è un’artista forse non particolarmente conosciuta presso il grande pubblico, ma la cui poetica avanguardistica ha influenzato molti autori dei decenni successivi. In particolare in Italia, sono poche le istituzioni pubbliche che hanno posto attenzione alla sua ricerca, tra questi emerge la Fondazione del Monte di Bologna che, in occasione di Arte Fiera 2020 ha inaugurato la mostra 3 Body Configurations in cui, insieme a Valie EXPORT e Ottonella Mocellin, vengono esposte 38 opere fotografiche dell’artista grazie alla collaborazione col Jersey Heritage Collection, dalla città dove Cahun ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e che conserva la maggior produzione della fotografa.


La durata dell’esposizione era prevista fino al 30 aprile, con la speranza di poter presto riaffollare (ma non troppo) i luoghi della cultura vi consiglio quindi di segnarvela in agenda!
Fonti:
– Silvia Mazzucchelli, Oltre lo specchio : Claude Cahun e la pulsione fotografica, Milano, Johan & Levi, 2013;
– Claude Cahun, Le scommesse sono aperte (Les paris sont ouverts, traduzione in italiano di Marcello Giulini e Marco Dell’Omodarme, prefazione di Silvia Mazzucchelli), Edizioni WunderKammer, 2018;
– Claudio Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Milano, Bruno Mondadori, 2012.