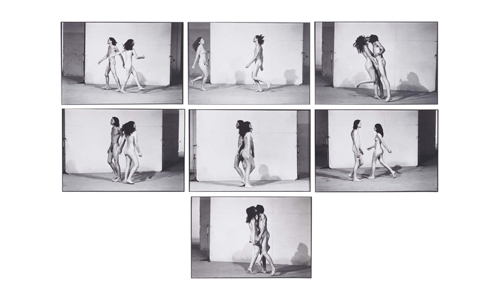Per innovazione si intende una modificazione di qualcosa attraverso l’introduzione di elementi di novità. Si tratta dunque di dare nuova vitalità a qualcosa che sta morendo. Essa è senza dubbio la chiave di volta della modernizzazione, ovvero il tentativo di far sopravvivere quel qualcosa alla nuova epoca che incombe.
Più andiamo avanti e più ci risulta complicato e arduo rinnovare, dare nuova vitalità alle cose morenti diventa sempre di più faticoso. Il tempo si restringe e aumentano i casi di resa di persone incapaci di stare a ritmo con il passo sempre più veloce della modernizzazione. La resa consiste nell’abbandono della sfida e immediatamente segue quello che è una totale incapacità di rialzarsi dalla caduta. L’infortunio ha come conseguenza un lungo periodo di nullafacenza e iniziamo ad abituarci, anche molto velocemente, a trovare comodo il nostro culo appoggiato per terra. Si entra inconsapevolmente nella casa della pigrizia, un luogo dove non c’è bisogno dell’invito ed entrarci è molto facile, totalmente l’opposto è, invece, uscirne. E che cosa comporta la pigrizia se non la totale indifferenza nelle cose che ci circondano?Iniziamo a non guardarci più attorno e più non utilizziamo i sensi per vivere e più la “vera realtà”(e non quella che ci siamo costruiti, quella che noi chiamiamo “quotidianità”) ci sembra sconosciuta. E come reagisce l’animale a qualcosa che non conosce? Indietreggia spaventato. Noi pigri indietreggiamo di fronte alla fatica. Così facciamo per ogni sfida che incontriamo sul nostro cammino: nello studio, nelle relazioni sentimentali, nelle promesse e anche, ahimè, nell’arte. Trattiamo tutto con superficialità, con banalità…con stupidità. Le avanguardie, le sfide che gli artisti si ponevano un tempo sono crollate, morte e sepolte nei libri di storia dell’arte. Oggi noi trattiamo l’arte non come fonte di vita, come atto sacrale della nostra esistenza. Questo perché anche nel mondo, anzi nell’universo dell’arte, soprattutto in questo luogo, c’è bisogno di impegno, di devozione ai limiti del religioso. La vita si basava sulla propria arte. In una piramide di importanza, la punta era l’ascesa artistica, la base invece la vita. I mattoni messi nel mezzo erano le opere artistiche. Oggi, invece, l’arte è diventata un hobby per chi saccentemente si definisce “appassionato” di quella o di quell’altra arte. Nel campo mio esistono i cinefili…che parola disgustosa. C’è molta più eleganza nella cinofilia che nella cinefilia. La gente che vive nella passione non si rende conto che essa è solamente la devozione dei pigri. E così, grazie soprattutto a internet, ci ritroviamo pagine e pagine di gente che recensisce film, che fa liste del cazzo e che vive solamente del gossip che sta dietro un’opera cinematografica. Parlo esclusivamente di cinema in questo articolo soprattutto per la mia delusione immensa nel vedere come quest’arte sia la più giovane tra le altre, ma sia anche quella che meno ha resistito a questo impulso di pigrizia. Nata nel finire dell’Ottocento, già a metà degli anni ’50 era diventata un passatempo per tappare i buchi vuoti della giornata. Amare il Cinema significa andare oltre alla semplice visione di un film. Andare a vedere un film, bello o brutto che sia, non basta. Bisogna vivere “sentendo” il cinema in continuazione. Che cosa si intende per “sentire”? Significa percepire costantemente il dolore dell’arte cinematografica in un’attualità così degradata a livello sensitivo. Ci vuole sensibilità, non solamente passione. E nel dire che bisogna trovare e avere sensibilità non intendo mica affermare che bisogna fare cinema. Per carità, altri registi inutili non ci servono…Per trovare questa benedetta sensibilità (risulterò ripetitivo nel dire di continuo “sensibilità”, ma è una parola talmente sconosciuta ai cinefili che bisogna martellargliela di continuo fino allo svenimento) bisogna scavare a fondo, capire che il cinema è dentro e fuori dalle sale cinematografiche. Bisogna vivere con essa a trecentosessanta gradi, tutti i giorni, fino alla morte. Anche qui, non intendo dire che bisogna vedere ogni singolo giorno quattro o cinque film, anche la mente ha bisogno di riposare a volte e il cinema è faticoso. Bisogna pensare e riflettere su quello che il cinema è, sul suo rapporto così intimo con la realtà. Bisogna capire la potenza che essa ci dona ogni volta che vediamo o pensiamo ad essa.
Questa lettera la dedico a tutti voi cinefili. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, non tutti sono così. Chi è cinefilo, però, sa bene che sto parlando di lui. A te, cinefilo che mi stai leggendo, non sentirti offeso e non pensare nemmeno che io mi ritenga superiore a te, perché anche io ho peccato, l’unica differenza tra me e te è l’ammissione delle proprie colpe e della propria stupidità. Io oggi sono come chi aiuta i tossicodipendenti: anche io sono stato un tossicodipendente e tutt’ora lo sono, ma ne sono consapevole.