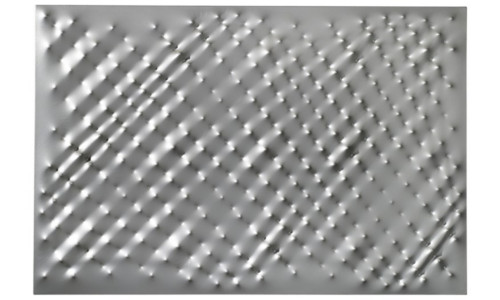Per conoscere uno dei più importanti artisti dell’arte povera, ovvero Mario Merz non ci si può fermare alla bellezza delle sue opere. Conoscere le sue fonti, significa fare un viaggio nella natura, nella progressione, nell’evoluzione, nella matematica: significa scontrarsi con la catena di Fibonacci.
Studiare arte, come più di una volta abbiamo cercato di sottolineare, non significa “leggere” un’opera dura e pura senza considerare altri fattori, che possono in qualche modo influenzare l’artista o il movimento stesso. Molte volte il periodo storico dà suggerimenti sul significato, libri e opere sono il centro di molti quadri, ma se una successione matematica potesse far nascere opere?
Stiamo parlando della serie di Fibonacci, una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti a parte i due iniziali, che sono 0 e 1; la catena, di conseguenza, semplice da indovinare, è 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…
Se vi parliamo di essa, non è perché siamo pazzi, bensì poiché molte volte è stata centro fondamentale di opere d’arte e fonte di ispirazione per molti artisti tra cui spicca l’italiano Mario Merz.


Questa sequenza matematica, non è solo presente a livello teorico, ma anche nella realtà! La Natura ci regala gli esempi più belli e la successione così diventa simbolo di perfezione; molti fiori, per esempio, hanno un numero di petali corrispondente ai numeri di Fibonacci: si passa dai tre petali del giglio ai tredici della calendula per non parlare della margherita, che può averne trentaquattro, cinquantacinque o ottantanove.
Questo dovrebbe aiutarci a capire come mai Mario Merz sia arrivato ad includere questa sequenza all’interno dei suoi lavori. Egli fu un esponente dell’arte povera, una delle principali correnti italiane di metà anni Sessanta: teorizzata da Germano Celant essa vede tra le sua fila importanti esponenti come Kounellis, Fabro, Ceroli, Pascali, Anselmo (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) e molti altri ancora. La loro poetica in poche parole consiste nell’andare contro alla tradizione pittorica della quale rifiuta supporti e materiali, preferendo ad essi quelli ritenuti appunto poveri come il legno, la plastica, il vetro e via dicendo. In essa poi ovviamente si possono riconoscere altre somiglianze ad altri movimenti a loro contemporanei, come la ripetitività della pop art, la deperibilità e l’importanza dell’hic et nunc della performance art di quegli anni.
Da sempre Mario Merz viene influenzato da questo richiamo magico, come fosse una linfa organica che influenza ogni sua idea e di conseguenza ogni sua opera e lui stesso ci spiega il perché
“non capivo perché un’opera d’arte dovesse avere una certa lunghezza quando poteva essere infinita… Nella serie di Fibonacci non ci sono limiti spaziali perché lo spazio diventa infinito: non astrattamente infinito ma biologicamente infinito”.
Quasi ossessionato, la spirale fibonacciana era già presente nella sua fase pittorica, ma è con l’entrata nel gruppo di Celant, che la sua fiducia nella successione diventa il centro. Lavorando tra organico ed inorganico, la successione non può che essere emblema dell’unione di questi due stati della materia. Vari esempi si possono suddividere in tre grandi insieme, che possono dettare la legge di tutti i suoi lavori: quelli in cui la catena è interpretata attraverso i numeri stessi, quelli in cui è invisibili e quelli che sono una via di mezzo.

Dove vediamo i numeri, ovviamente, è evidente il richiamo e uno degli esempi più belli è la Mole antonelliana a Torino, illuminata da un lato dalla infinita successione: da un paio d’anni ogni torinese e ogni turista ha la fortuna di alzare lo sguardo e vedere questa magnifica installazione, che non è più illuminata solo per Luci d’artista, ma ogni giorno.

Molte volte invece la catena è invisibile: non ci sono cifre a raccontare l’evoluzione, ma ci sono oggetti, che al suo interno presentano proprio la successione, come i suoi famosi igloo. Utilizzando vari materiali, Mario richiama questa essenziale abitazione e indovinate un po’? Vista dall’alto, se noi immaginassimo di disegnare una spirale, diventerebbe proprio quella corrispondente alla successione di Fibonacci.

Ultimo insieme, quello misto: molte volte accanto a natura o oggetti troviamo i numeri della successione, come se volesse farci ragionare proprio sulla perfezione della creazione o sull’impossibilità di bloccare il ritmo incessante e costante dell’evoluzione.Ecco perché è importante viaggiare tra vari saperi per risolvere intricate opere, non ci si può bloccare all’evidenza dei numeri: cosa sono? Perché sono lì? Cosa voleva raccontarci? La lettura di un’opera è sempre un terno al Lotto, un po’ ogni curatore racconta la sua visione, ogni mostra il suo modo di approcciarla e ogni libro la sua teoria, ma la verità è che artisti così complicati confondono sempre: Mario Merz passa da organico ad inorganico, da pesantezza dei materiali a smaterializzazione, lasciandoci solo questo piccolo indizio, la catena risolverà ogni nostro dubbio.
Fonti
– Renato Barilli, L’arte contemporanea Da Cézanne alle ultime tendenze, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2011.
-FAM, Per-corsi di arte contemporanea. dall’impressionismo a oggi, Skira, Milano, 2011.